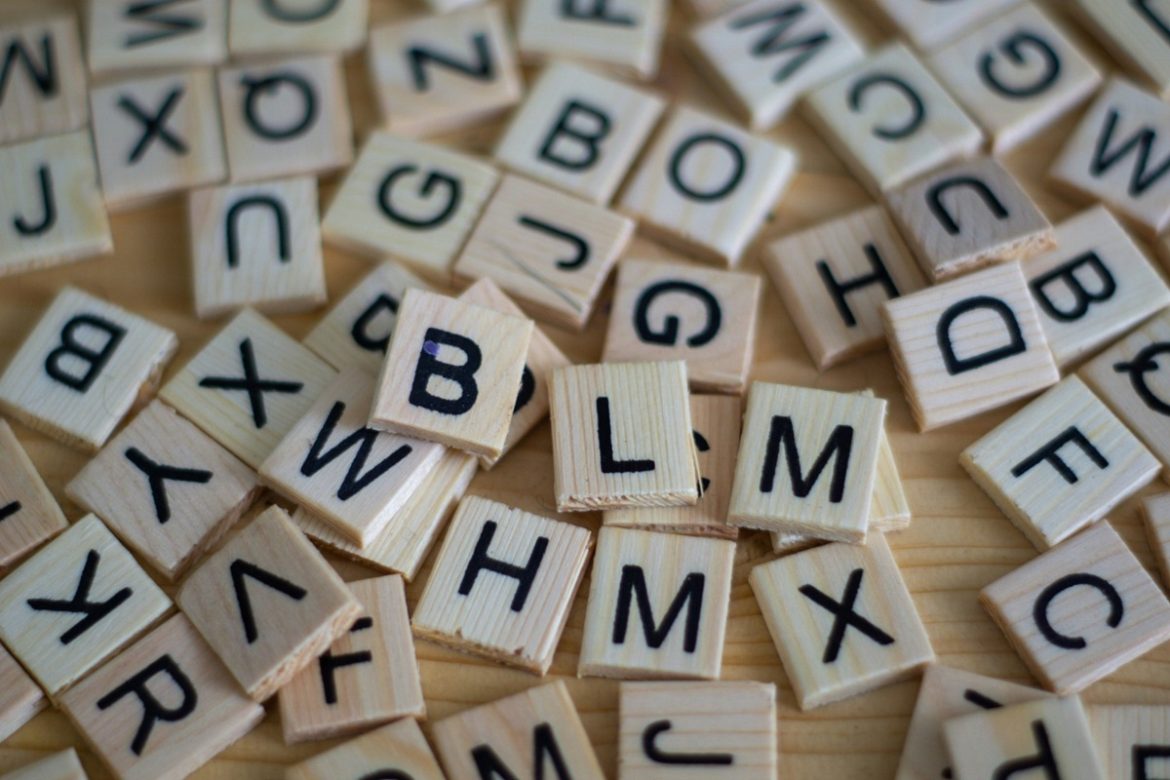“La difficoltà più grande dei ragazzi è diventata comprendere ciò che leggono”. Tiziana D’Avello insegna alle elementari e da anni con i colleghi osserva lo stesso fenomeno: scolari che sanno leggere ma non capiscono.
Che non si tratti di casi isolati lo dimostra l’ultimo rapporto Ocse sull’istruzione. In Italia il 37% degli adulti è analfabeta funzionale. Dieci punti sopra la media degli altri Paesi sviluppati, ferma al 27%. Significa che più di un italiano su tre sa leggere, ma non riesce a comprendere, valutare e usare un testo per “intervenire attivamente nella società”, proprio come recita la definizione cristallizzata dall’Unesco nel 1984.
Il Sud paga il prezzo più alto
Nel Paese la situazione non è omogenea. Nel Nord-Est la percentuale migliora rispetto alla media nazionale, superando gli standard Ocse. Invece, nel Mezzogiorno e nelle isole si supera il 50%. Oltre la metà della popolazione adulta. Numeri che riflettono disparità socio-economiche profonde: minori investimenti in istruzione, meno opportunità lavorative ed emigrazione dei più istruiti.
Le conseguenze si vedono sul mercato del lavoro. “Persone con scarsa produttività generano tassi di occupazione più bassi”, spiega a Lumsanews Michele Pellizzari, docente di Economia del lavoro all’Università di Ginevra. I lavoratori meno produttivi, infatti, possono avere più difficoltà a trovare un impiego o a ritrovarlo quando lo perdono. E spesso, quando ce l’hanno, sono retribuiti con salari più bassi. Non solo. “I lavoratori con competenze poco sviluppate – aggiunge – possono incentivare le imprese a investire di più nelle tecnologie che possono sostituirli”.
La forbice è netta. Tra i 25-34enni senza un titolo secondario, il 14,8% è disoccupato. Tra i laureati la percentuale crolla al 6,5%. Eppure la Penisola è il fanalino di coda europeo per numero di corone d’alloro: solo il 32% della popolazione – uno su sei – ha completato l’università. Peggio di noi nel mondo solo il Messico fermo al 29%.
La trappola dell’ascensore sociale
Il problema si autoalimenta attraverso una mobilità sociale bloccata. Dei ragazzi nati in famiglie con un basso tasso d’istruzione – massimo la terza media – solo il 15% riesce a tagliare il traguardo del titolo universitario. “È questo il problema principale del sistema educativo italiano”, sottolinea Pellizzari.
Ma le conseguenze non si fermano al lavoro e al completamento degli studi terziari. “La malcomprensione è un concreto rischio per la democrazia”, avverte Chiara Saraceno, professoressa emerita di Sociologia dell’Università di Torino. ”Non si è competenti nel capire come va il mondo e si è molto passivi rispetto a quello che succede. Le persone sono più vulnerabili alle fake news e allo sfruttamento”. Un pericolo sempre più attuale dato che il fenomeno “non consente una partecipazione competente e c’è una difficoltà nella formazione della propria opinione”.
Anche chi riesce a diplomarsi o laurearsi non è immune. “Si rischia di ripetere più o meno scimmiottando quello che si trova sui libri. Si impara a memoria, senza comprensione e non si riesce a andare aldilà delle parole prese dai libri”, denuncia Massimo Arattano, primo ricercatore del Cnr. Mentre Marco Valentini, esperto di apprendimento strategico, racconta di ragazzi che arrivano alla laurea senza aver davvero imparato a studiare. “Troppo spesso – spiega – mi capita di sentire giovani che hanno studiato per anni e hanno ancora quella quella paura di non aver capito bene, quella speranza di ricordare tutto. Concretamente si rischia di terminare gli studi, avere un pezzo di carta però non aver effettivamente maturato un’abilità”. I pericoli? “Perdita di fiducia in se stessi e di motivazione allo studio”.
E poi c’è l’intelligenza artificiale. “In una società così fluida, dove le informazioni sono più immediate rispetto al passato e i giovani non sono più abituati al ragionamento”, afferma la maestra D’Avello, “l’uso dell’IA può diventare un danno, se non guidato”. Il rischio è che queste piattaforme vengano utilizzate da chi non ha ancora sviluppato l’abilità alla deduzione e al ragionamento.
Una scuola sottofinanziata
In tutto ciò viene da chiedersi dove sono le istituzioni. “Il tempo e le risorse sono poche per arginare il problema”, conferma D’Avello. I numeri le danno ragione: le spese totali per università e ricerca fra pubblico e privato sono pari all’1% del Pil contro una media Ocse dell’1,4%. Percentuale che scende allo 0,6% se si guarda solo alla spesa pubblica.
Qualcosa però si muove. Esistono realtà parallele che promuovono set di strumenti e metodi di studio cuciti sulla persona. La campagna “Accendi la Tua Intelligenza” promossa dall’azienda “Genio in 21 giorni” e il team SaperCapire del Cnr punta a insegnare i “Fondamentali dell’Apprendimento”. “Sono gesti cognitivi che possiamo definire le basi dell’apprendimento, così come nel tennis esistono dei gesti tecnici di base che vanno costantemente allenati”, spiega il ricercatore del Cnr Arattano. I risultati sono incoraggianti. “Su un campione di più di mille studenti abbiamo osservato miglioramenti significativi di oltre l’80% a distanza di tre, sei, nove, dodici e addirittura 24 mesi”, racconta Valentini.
Una zona grigia che, nonostante i nuovi metodi di apprendimento per invertire la rotta, continua a crescere nell’ombra e che condiziona opportunità, salari e diritti, causando difficoltà nell’orientarsi nella complessità del presente. A scuola, al lavoro e nella vita quotidiana l’analfabetismo funzionale decide chi può partecipare e chi resta indietro. È anche da qui che passa il futuro del Paese.